Chi siamo
Nella sessione autunnale della loro Conferenza (Pergusa 9-10 Ottobre 1995), i vescovi delle Chiese di Sicilia hanno deciso la istituzione del Centro Madre del Buon Pastore quale struttura
permamente a sostegno e per la realizzazione del Progetto di Formazione permanente per il clero di Sicilia.
A seguire il documento che, redatto dalla CESi nel novembre del 1995, consente di comprendere le ragioni e le finalità della Formazione permanente.
Progetto per la Formazione permanente del clero di Sicilia
Conferenza Episcopale Siciliana – Novembre 1995
Conferenza Episcopale Siciliana – Novembre 1995
PREMESSA
DECISIONE DEI VESCOVI DI SICILIA
In ottemperanza a quanto prescritto dalla Esortazione Apostolica “Pastores dabo vobis” del Santo Padre, Giovanni Paolo II, e dal Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri della Congregazione per il Clero , accogliendo uno dei principali voti del 3° Convegno Ecclesiale siciliano (Acireale 1993), convinti, dinanzi alle sfide epocali del tempo presente, alle soglie del terzo millennio dell’era cristiana, dell’urgente necessità della Formazione Permanente dei presbiteri, i Vescovi delle Chiese di Sicilia, nella sessione autunnale della loro Conferenza (Pergusa 9-10 Ottobre 1995), hanno deciso la istituzione del Centro Madre del Buon Pastore quale struttura permamente a sostegno e per la realizzazione del Progetto di Formazione permanente per i presbiteri di Sicilia.
La elaborazione di questo Progetto è stata affidata dalla stessa Conferenza Episcopale alla Commissione Presbiterale Siciliana, con la precisa indicazione, contenuta nel documento “Nuova Evangelizzazione e Pastorale“, “si tratta di predisporre, attraverso le opportune consultazioni su scala regionale, un serio progetto unitario di FP dei presbiteri e il relativo programma attuativo, che preveda anche forme e modi di avvicendamento e sostituzione temporanea dei Confratelli impegnati nello studio. In un momento successivo, dopo che sarà predisposto il programma, daremo l’avvio all’attuazione dello stesso” (45).
La Commissione Presbiterale, nelle riunioni del 15-16 Febbraio 1995 a Capaci, e del 16 Marzo a Cefalù e il suo Direttivo nella riunione del 7 Marzo a Gela, hanno elaborato le linee fondamentali di un possibile progetto, che è stato presentato alla Conferenza Episcopale Siciliana il 17 Aprile a Troina.
Sulla base delle indicazioni date dai Vescovi il Progetto è stato rielaborato dalla Commissione nella riunione del 10-11 Maggio nell’Isola di Formica, e dal Direttivo, il 17 Maggio a Pergusa. Successivamente la Conferenza Episcopale ne ha fatto oggetto di ulteriore riflessione, nella seduta straordinaria, tenutasi a Roma, nei giorni dell’Assemblea generale della CEI del Maggio 1995 e in quella di Pergusa, ove il Progetto è stato definitivamente approvato.
“I Vescovi hanno ulteriormente esaminato il «Progetto» per la Formazione Permanente dei Presbiteri di Sicilia, tema già altre volte affrontato e che riveste crescente urgenza per la vita delle nostre Comunità ecclesiali. Il Progetto, suggerito insistentemente dalla Commissione Presbiterale Siciliana e responsabilmente accolto dai Vescovi, si avvia ormai ad una promettente prima fase di attuazione, ultimati cha saranno, a breve termine, alcuni previ adempimenti.Il Progetto, offrendo ai Sacerdoti Siciliani una permanente formazione umana, spirituale, culturale e pastorale, contribuirà a renderli sempre più preparati a vivere e a svolgere il ministero nelle presenti contingenze così impegnative. Affinché tale «Progetto» possa realizzarsi nelle modalità più opportune, la C.E.Si. costituisce un apposito Centro regionale, denominato “Madre del Buon Pastore” che troverà sede appropriata e strutture adeguate.I Vescovi invitano i fedeli ad invocare la protezione della Vergine Santissima, Madre dei Buon Pastore, sul Centro affinché esso possa rispondere alle fondate speranze di felice e feconda attività in esso riposte” (Comunicato C.E.Si. sessione autunnale Pergusa 9-10 ottobre 1995)
PROGETTO
LE RAGIONI DELLA FORMAZIONE PERMANENTE
1. “La Formazione permanente (FP) è esigenza che nasce e si sviluppa a partire dalla recezione del Sacramento dell’Ordine, il quale è dono divino che va continuamente vivificato, fino al dono totale di se stessi (cf Dr. 69). Infatti “la chiamata di Gesù dà origine a un dialogo ininterrotto, esige una risposta sempre nuova e una configurazione progressiva a Lui, Buon Pastore, in un impegnativo ed esaltante itinerario di conversione e di crescita spirituale all’interno di una esistenza interamente votata al ministero” (CEI p. 10).
2. La FP si rivela sempre più urgente, per la intrinseca legge di sviluppo di ogni esistenza, per il progresso delle discipline teologiche e delle scienze umane, per superare i disagi che facilmente sorgono quando persone di età e formazione diverse debbono operare insieme, per il mutarsi rapido delle condizioni culturali e sociali, per la Nuova Evangelizzazione (cf FPCI, Appendice, 2; PDV 70).
3. La FP permette al presbitero di essere e di fare il prete oggi nello spirito e secondo lo stile di Gesù Buon Pastore (PDV 73). Tale formazione deve comprendere e armonizzare tutte le dimensioni della formazione sacerdotale (umana, spirituale, culturale, pastorale) e deve essere sistematica e personalizzata (cf PDV 71-72; Dir. 74-80).
4. La FP proprio perché “permanente” accompagna il presbitero in tutte le stagioni della sua vita presbiterale come pure ad ogni livello di responsabilità ecclesiale.
Per questo già negli anni del Seminario, va curata una opportuna presentazione della sua necessità, dei suoi vantaggi e delle sue ragioni, ai futuri sacerdoti perché si radichi in essi la convinzione profonda che la formazione, acquisita in Seminario, richiede uno sviluppo armonico e vitale, senza soluzioni di continuità, in un impegno organico di formazione permanente, perché essa altro non è che un incessante conversione all’appello e al dinamismo dello Spirito. (FDCI, Appendice, nn. 2-4; PDV 76-77).
5. La FP è un diritto – dovere del presbitero e impartirla è un diritto – dovere della Chiesa (PDV 78-79; DIR. 72).
LA FORMAZIONE PERMANENTE È URGENTE
6. Perché oggi il presbitero si rende conto di trovarsi nel trapasso di un’epoca e dinanzi a sfide culturali di portata storica (divergenza religiosa, inculturazione della fede, società complessa, postmodernità, ecc), che provocano e interpellano il suo essere e il suo operare, nonostante la sua generosa donazione, dinanzi a tale situazione, egli, spesso, sperimenta profondo disagio e interiori lacerazioni.
7. Perché oggi i! presbitero condivide l’anelito della Chiesa a mettersi in stato di evangelizzazione, sente il bisogno di abilitarsi ad operare per il passaggio da un cristianesimo di “tradizione”, ad un cristianesimo di convinzione e di scelta.
L’inadeguatezza dei “modelli” pastorali può indurre non pochi presbiteri a cercare rifugio nella rassicurante ripetitività o nella cura preminente dei “praticanti”, “ad intra”, affievolendo lo slancio missionario e l’audacia nell’affrontare i grandi eventi della storia alla luce del Vangelo. Tutto ciò concorre a provocare nel prete senso di smarrimento e di inutilità, di sfiducia e di isolamento.
8. Perché oggi i presbiteri avvertono la necessità di proseguire con passo più spedito nell’attuazione dell’ecclesiologia di comunione del Vaticano II, la quale apre vie di “novità”:
a) Per potenziare e diffondere una concezione “ecclesiale” del ministero, capace di far superare quella visione individualistica che spesso inclina a forme soggettive, privatistiche e unilaterali.
b) Per riscoprire e potenziare l’unico Presbiterio nella Chiesa locale, come luogo e strumento della comunione che lega tutti i presbiteri tra loro e con il vescovo, come ambiente vitale da cui e in cui possono svilupparsi un’autentica fraternità sacramentale e un rinnovato slancio missionario. L’accoglienza, la conoscenza e la comunicazione facilitano il superamento delle fratture tra le varie generazioni di presbiteri.
c) Per armonizzare la loro vita e il loro ministero con il progetto pastorale della Chiesa locale, ricercato insieme al Vescovo, ai confratelli e ai fedeli.
d) Per acquisire una mentalità di “progettualità” e abilitarsi ad operare secondo un coordinamento pastorale, evitando la frammentazione e l’inefficacia.
e) Per conoscere, curare, promuovere le diverse vocazioni per l’edificazione della Chiesa e il servizio da rendere al mondo. Tale presa di coscienza aiuta a colmare quelle carenze, conseguenze di un certo persistente clericalismo, evidenziate dal Documento Pastorale CESi “Nuova Evangelizzazione e Pastorale” (n, 25).
FINALITÀ DELLA FORMAZIONE PERMANENTE
9. II presbitero si contempla e si confronta con l’icona del Cristo Buon Pastore, dinanzi alla quale con gioia rende grazie per le somiglianze, e invoca perdono e supplica grazia per le differenze.
Questa configurazione pone il presbitero in costante cammino di fede verso la sorprendente novità di vita in Cristo. In questo legame tra il Signore Gesù e il presbitero, legame ontologico e psicologico, sacramentale e morale, sta il fondamento e nello stesso tempo la forza per quella “vita secondo lo Spirito” e per quel “radicalismo evangelico” al quale egli è chiamato.
10. La FP esige il coraggio di mettersi in discussione, non solo per il modo in cui si opera, ma ancor più per il modo in cui si spende la propria esistenza. Richiede I’umiltà di attingere alle sorgenti della fede e della grazia del Mistero posto nelle proprie mani, per rimotivare il dono totale di sè. Spinge a cercare modi attuali e significativi di servizio, per aiutare i cristiani a saper stare nel mondo come sale, luce e lievito.
11. Le finalità di tale FP non sono raggiungibili con il “ritorno a scuola” né con il semplice aggiornamento, né con lo studio della programmazione pastorale.
12. Per “ravvivare il dono ricevuto” la FP aiuta il presbitero a:
a) crescere in quegli atteggiamenti specificatamente cristiani (fede, speranza e carità) che lo definiscono discepolo fedele del Maestro;
b) rafforzare il rapporto personale con Colui che lo chiama e lo configura a sua immagine di Servo obbediente, di Sposo fedele, di Povero fiducioso, di Pastore buono;
c) riscoprire la propria identità (umana, cristiana, presbiterale) verso la sintesi esistenziale del sacramento e della missione nella carità pastorale.
13. Per ripensarsi presbiteri in prospettiva ecclesiale la FP aiuta il presbitero a:
a) recuperare la fraternità sacramentale, comprensibile nella fede, che lega i membri dei presbiterio (Vescovo, presbiteri: diocesani e religiosi). Tale fraternità è insostituibile risorsa per superare chiusure o pregiudizi, salutare medicina contro le crisi che inevitabilmente visitano l’esistenza dei sacerdote;
b) valorizzare occasioni e luoghi per una personale conoscenza dell’altro al di là del sentito dire, per crescere nella reciproca stima, per dialogare con lealtà e rispetto;
c) scoprire, senza invidia e gelosia, le proprie doti e capacità, e quelle degli altri, che sono risorse preziosissime da investire nell’edificazione della Chiesa;
d) valorizzare le differenze (di età, temperamento, esperienze, cultura, ministero) nella costruzione del presbiterio unico, considerato non come casta, ma come famiglia a servizio della Chiesa per l’unica causa;
e) pensarsi e comportarsi da ministro a servizio della ministerialità del Popolo di Dio, perché crescano la corresponsabilità e la partecipazione a tutti i livelli, fugando !a tentazione delle assolutizzazioni e dei clericalismi vecchi e nuovi;
f) condividere la fatica del credere e del convertirsi con i fratelli e confratelli, riconoscendosi fratello tra fratelli e raccordando il cammino presbiterale con il progetto che il Vescovo dona alla propria Chiesa locale.
14. Per accogliere le sfide del tempo presente e partecipare alla fatica del rispondervi, la FP aiuta il presbitero a:
a) superare la tentazione di chiudersi, nostalgico del passato, o di ripiegarsi su se stesso, impaurito del “nuovo” che scomoda, provoca e interpella;
b) imparare a vegliare come sentinella a custodia dei più deboli;
c) abilitarsi al sano discernimento dinanzi agli eventi del mondo per scorgere le sue povertà e i segni di speranza che il Signore non si stanca di seminare nei solche della storia;
d) attrezzarsi al dialogo nella Chiesa e con le diverse realtà del mondo, cogliendone le sensibilità, le possibilità, le vie per annunziare il Vangelo in un linguaggio significativo e interessante per l’uomo contemporaneo;
e) accettare con pazienza e umiltà lo sforzo del coordinamento pastorale e la fatica della ricerca di modelli pastorali adeguati.
IL CENTRO “MADRE DEL BUON PASTORE”
15. II Centro è la struttura regionale, voluta dalla C.E.Si., per la FP dei presbiteri, affinché, unendo le forze, si possano offrire iniziative più qualificate e veramente stimolanti (cfr PDV 79; Dir. 91), ad integrazione e supporto delle attività previste nelle diocesi.
16. Poiché il presbitero si santifica nel ministero e attraverso il ministero, è nei luoghi della quotidianeità (parrocchia, unità e zone pastorali, presbiterio) che gli dovranno essere offerte le prime occasioni di formazione permanente. Pertanto, la funzione delle singole Chiese locali non è assolutamente sostituibile da alcuna iniziativa sopradìocesana.
17. II Centro è struttura permanente (con gruppo stabile di responsabili, sede propria ecc.), collegata per certi aspetti alla Facoltà Teologica Siciliana e alle altre Istituzioni di formazione teologica e culturale, e per altri alla Commissione Presbiterale Siciliana e alla Segreteria Pastorale della CESi.
18. La Presidenza del Centro è affidata al Vescovo delegato per il Clero; mentre i Responsabili saranno, almeno tre Presbiteri, scelti dalla Conferenza Episcopale Siciliana tra Presbiteri delle Chiese locali, che i relativi Vescovi destinano a tempo pieno a tale servizio, almeno per un triennio.
19. La scelta dei Responsabili va fatta tenendo conto della natura del Centro e del servizio che esso intende offrire: Presbiteri stimati per la loro maturità umana, spirituale, culturale e pastorale, capaci di ascolto e di dialogo, preparati a specifiche competenze, idonei a stare in mezzo ai confratelli soprattutto come autentici educatori e guide.
20. I Responsabili avranno la responsabilità immediata e diretta del Centro e si avvarranno della collaborazione, stabile o temporanea, di persone competenti e qualificati: presbiteri, religiosi e laici.
21. II Centro dispone di una sede adatta al tipo di iniziative che intende attuare. Nel tempo, essa dovrebbe acquisire le caratteristiche di una “Casa del Clero” (Dir. 84): luogo confortevole e attraente, adeguatamente attrezzato, e, possibilmente, vicino ad altre strutture di cui ci si può avvalere per le diverse eventuali necessità. Oltre a queste condizioni materiali, è importante che il Centro divenga punto di riferimento soprattutto per l’ambiente umano che vi si incontra.
Le difficoltà di reperire una struttura con tali requisiti non dovrebbe condizionare I’avvio delle attività, perché intanto si potranno utilizzare temporaneamente strutture alternative.
22. Per favorire al massimo la partecipazione di tutti i presbiteri, le singole Chiese si faranno carico della spesa necessaria per la realizzazione del progetto (anche di quella per l’accoglienza dei singoli partecipanti). Le spese potrebbero essere coperte attingendo ai fondi CEI dell’8 per mille e delle Messe binate. Non sarebbe inopportuno che le comunità, in qualche modo, contribuissero a tali spese.
23. Destinatari del servizio sono i presbiteri: diocesani e religiosi, lasciati liberi da responsabilità pastorali dirette per un congruo “tempo sabatico” (Dir. 83). (Vanno studiate le soluzioni alle varie difficoltà che sorgeranno nel momento in cui i sacerdoti si assenteranno per partecipare al “mese sabatico”).
24. II Centro programmerà ogni iniziativa che riterrà utile agli scopi anzidetti. Certamente sarà necessario programmare iniziative destinate specificatamente a presbiteri delle diverse età o in specifiche situazioni: esse saranno oggetto di ulteriore riflessione. Intanto si ritiene opportuno avviare le attività del Centro con l’organizzazione di periodici “Mesi sabatici”, destinati a tutti i presbiteri, senza distinzioni. Questa scelta potrebbe favorire la conoscenza, l’interscambio, la comunione.
25. II “Mese sabatico”, caratterizzato da un clima di serena fraternità e di forte spiritualità, sarà ritmato in tempi forti di preghiera e di revisione di vita, di riposo e di distensione, di studio e di ricerca su tematiche urgenti (teologiche, morali, pastorali, spirituali e culturali), di confronto e di sperimentazione pastorale.
Questa iniziativa non avrà, quindi, lo stile di scuola, né di semplice corso di aggiornamento.
26. Spetta ai Responsabili del Centro programmare il “Mese Sabatico” (obiettìvi, contenuti, metodi, attività, ecc.) nella fedeltà alle finalità della FP e alle idee di fondo espresse in questo progetto. È necessario che le attività e le iniziative del “Mese sabatico” siano “personalizzate” affinché risultino rispondenti ad ogni partecipante.
27. Nella fase dì programmazione, specialmente della prima edizione del “Mese sabatico” e comunque dell’intero primo triennio, i Responsabili si avvarranno della collaborazione di un apposito “Gruppo di lavoro”.
28. Oltre alle attività organizzate in sede, i Responsabili cureranno ogni possibile servizio alle singole diocesi e soprattutto saranno a disposizione dei singoli presbiteri in ogni loro eventuale necessità.
Condividi

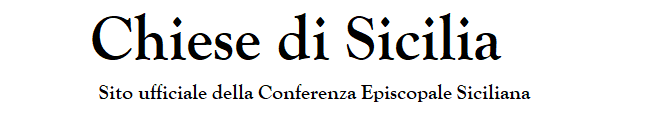
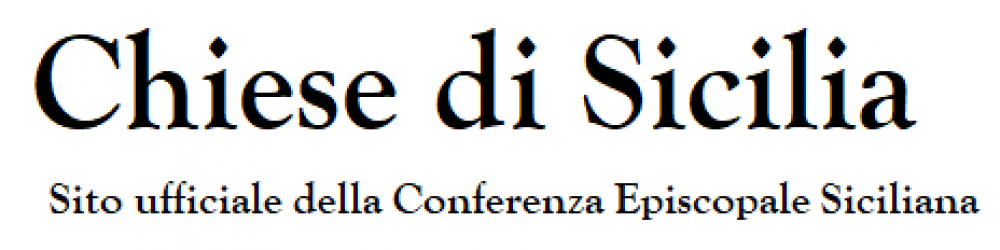




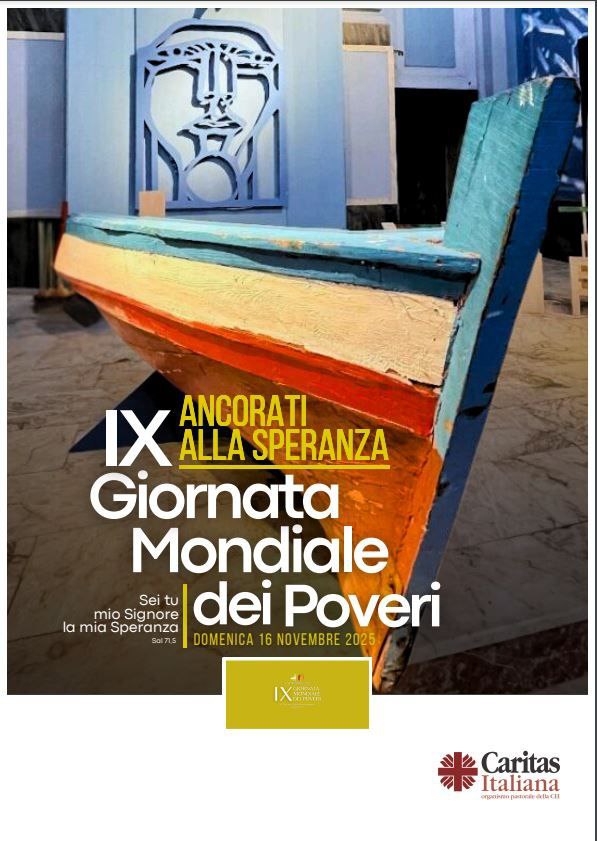








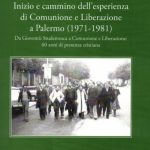

Condividi